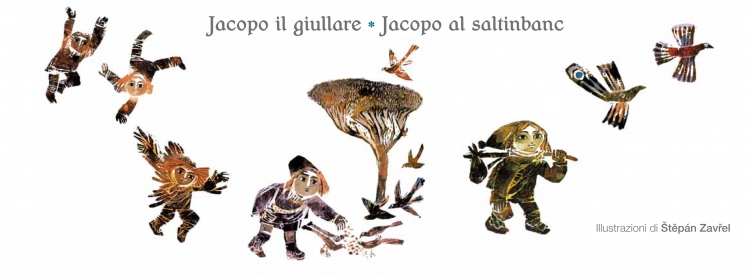
Quando è nato il Circolo culturale Menocchio?
Il Circolo culturale Menocchio è nato nel 1989, come emanazione autonoma della Biblioteca civica
di Montereale Valcellina. Ne è presidente Rosanna Paroni Bertoja.
Nel 1976 era uscito uno studio per vari aspetti innovativo di Carlo Ginzburg Il formaggio e i vermi
che riportava alla memoria la vicenda di uno fino a quel momento sconosciuto mugnaio di Montereale,
Domenico Scandella detto Menocchio, bruciato sul rogo a Portogruaro come eretico relapso, recidivo,
nei primi giorni di agosto del 1599. Oltre che mugnaio, Menocchio era stato amministratore (cameraro)
della pieve di S. Maria di Montereale, stimatore di beni, contadino, falciatore, muratore, falegname,
suonatore di zitara nelle feste di paese. Sapeva leggere, scrivere e far di conto. Leggeva e ripensava.
Era una persona che rappresentava gran parte della comunità locale. Dopo la ristrutturazione successiva
al terremoto del 1976, a Menocchio fu intitolato il Centro sociale e, successivamente, il Circolo culturale.
Ci furono anche alcune preconcette ma prevedibili opposizioni.
La nascita del Circolo ha una motivazione locale?
Sì e no. Uno dei temi storiografici del libro di Ginzburg era tentare di capire che cosa accade
quando culture diverse si incontrano. Nel caso di Menocchio la cultura scritta, colta, e quella orale,
popolare.
Su questa idea di fondo, delle diversità che si incontrano, si mescolano, si scontrano, si rifiutano, si
accettano, si assimilano, dialogano e, comunque, si arricchiscono reciprocamente - come, quanto, quando,
perché (Un mondo complesso da interrogare e da far parlare. Senza cadere nei localismi identitari) -
nascono i "progetti" del "Menocchio": Attorno a Menocchio, Diverse culture, Tra
archeologia e storia, Poesia, Con diverse lingue, Faccio coriandoli col computer (razionalità e
fantasia), Illustrazione per ragazzi, Università della Prima Età. Facoltà del libero perché, Libro
condiviso: nè al rogo né al macero ´in viaggio´ (1999) e di conseguenza, poco dopo ´biblioteca in
osteria´ ´prendo uno lascio uno´...
Prendono avvio anche alcune collane editoriali collegate ai "progetti" e realizzate quasi tutte in
collaborazione con altri. Lavorando insieme si fa di più e si fa meglio. E si spende meno, tutti.
Secondo alcuni, il localismo è una specie di subdola malattia mortale per chi si occupa di
cultura...
Certamente. Il lavoro nel campo culturale non è facile. Ma è - o dovrebbe essere - un servizio
pubblico. E in quanto tale deve proporsi di aprire o segnalare anche localmente nuove strade di
interesse e di approfondimento per evitare la devastante chiusura nel localismo asfittico e
autogratificante.
Si tratta cioè di creare le condizioni per una promozione della informazione e della conoscenza,
con particolare attenzione ai risultati delle ricerche di settore più avanzate ed aggiornate. Cioè, di
dare sistematicità a processi di alfabetizzazione e rialfabetizzazione, diffusi e continui. Altrimenti
il "diritto/dovere alla "cittadinanza consapevole" e " la necessità dell´innovazione" oltre ad essere
espressioni ingannevoli, rimangono chiacchiere che servono a muovere l´aria o a gestire,
apertamente o subdolamente, il consenso di parte.
Quale è stato il rapporto del "Menocchio" con le Istituzioni?
Le Istituzioni - in particolare la Regione Friuli Venezia Giulia, ma anche la Provincia di
Pordenone, e il Comune di Montereale Valcellina - hanno dimostrato attenzione e stima per le
attività del "Menocchio", ormai largamente note ed apprezzate anche fuori regione e a livello
internazionale. Questo impegna/costringe a far sempre meglio, con umiltà, giorno dopo giorno. Con
il massimo della qualità possibile, con serietà e con sobrietà.
L´inserimento tra le Associazioni culturali riconosciute di interesse regionale, ha consentito al
"Menocchio" un salto di qualità nella progettazione che da annuale è diventata pluriennale.
Il "Menocchio" è una Associazione che si basa sul volontariato. Quanti sono i suoi
collaboratori?
Invece che sul "volontariato”, direi piuttosto sul "lavoro gratuito", il quale nella sostanza e
nel concreto è spesso qualcosa di assai diverso.
Una leggenda africana, che piace citare, racconta di un incendio nella foresta. Tutti i grandi
animali, "i padroni della foresta" - leoni, tigri.ecc, - fuggivano lontano dalle fiamme. Un piccolo
colibrì, invece, con una goccia d´acqua nel becco volava verso le fiamme. Il leone gli gridò: «Credi
di poter spegnere l´incendio con la tua goccia d´acqua?!». Senza fermarsi il colibrì rispose
tranquillamente: «Faccio la mia parte».
Ogni anno i ´colibrì´che ´regalano´ le loro gocce d´acqua attraverso il "Menocchio" sono circa un
migliaio, tra studiosi affermati, giovani ricercatori, appassionati, manovali specializzati e generici,
di qui oppure no, friulani e non, italiani e non: chi una cisterna piena, chi un secchio,chi una goccia.
Ma, a ben pensare, in qualsiasi acqua ogni goccia vale ed è imnportante come ognuna delle altre.
Il "Menocchio" nel contesto culturale generale si accontenta di portare la sua goccia d´acqua, come
il ´colibrì´. Con la dovuta sobrietà e umiltà.
Si usa dire: dal locale al generale e viceversa...
Pensiamo che non ci sia nulla di più generale del locale. Basta non fermarsi alla superficie ma
cercare in profondità, sotto e attorno.
Il Menocchio opera in precisi contesti sociali di riferimento. Dunque è da qui che guarda ciò che
sta intorno. Lingue locali comprese, che fanno parte della storia e della vita della gente: qui e
altrove. E tra le lingue locali ci sono anche quelle parlate dai nuovi concittadini arrivati tra noi da
tutte le parti del mondo. Una opportunità e una occasione straordinarie e nuove, di crescita anche
culturale e di mentalità. In una comunità multilingue e multiculturale. Con più occhi che guardano,
e mettono insieme saperi diversificati, si va più lontano e si rischia meno di perdersi nella boscaglia
delle complessità o di prendere un sentiero sbagliato o che non porta da nessuna parte.
Quale l´atteggiamento del "Menocchio" nei confronti del problema: Friulano sì / Friulano no?
Si tratta, in quanto tale, di un problema che, guardato dal basso, cioè dalla realtà concretamente
vissuta dalla maggior parte della gente, pur avendo sue motivazioni, è in gran parte inventato.
Comunque, un falso problema.
C´è un dibattito vivace attorno ad esso, ma in parte distorto e disancorato dalle realtà concrete,nelle
quali si può facilmente notare che diversamente da qualche decennio quando lingua materna e
lingua ambientale era il friulano nelle sue singole varietà locali, ora per la maggior parte dei
bambini non è così. È auspicabile che l´ambiente linguistico, anche nella scuola, diventi sempre più
vario e ricco. Ciò pone con urgenza la necessità della formazione plurilingue degli insegnanti, di
tutti gli insegnanti. Soprattutto di quelli della scuola per l´infanzia e della scuola primaria.
Il "Menocchio" ha fin dall´inizio sostenuto, e sostiene ancora nel suo fare concreto, l´uso e la
valorizzazione delle parlate e delle varietà locali.
Qualche anno fa ad una signora delle nostre parti che compiva cento anni fu chiesto come avesse
fatto ad arrivare in ottima salute fisica e mentale fino a quell´età. Chi la intervistava si aspettava che
dicesse che il segreto stava, ad esempio, nell´aver bevuto un sorso di grappa ogni mattina, nell´aver
fumato regolarmente la pipa o aspirato una presa di tabacco. La centenaria rispose tranquillamente:
«Mangiando».
Immaginiamo di rivolgere una domanda simile alla lingua friulana o, meglio, a una sua varietà:
«Come hai fatto a sopravvivere per tanto tempo?». La risposta più naturale, e in fondo ovvia, da
vecchia saggia, dovrebbe essere: «Perché sono stata parlata». Il resto (scuola, grammatiche, ecc.) a
fare da cornice funzionale, come il bicchierino di grappa e la ´presa´ di tabacco da naso.
Federico Tavan ha trovato a Montereale, nella Biblioteca civica prima e nel Circolo
Menocchio poi, un approdo e un trampolino ...
Certamente. E gliene siamo riconoscenti. Come siamo riconoscenti a molti altri poeti: Elio
Bartolini, Emanuele Bertuzzi, Novella Cantarutti, Pierluigi Cappello, Antonio De Biasio, Erri De
Luca, Beno Fignon, Lionello Fioretti, A. Flyerns, Tito Maniacco, Carlos Montemayor, Stefano
Montello, Rosanna Paroni Bertoja, Giulio Trasanna, Umberto Valentinis, Ida Vallerugo, Ahmet
Zirek...e diversi altri, compresi i bambini "poeti involontari".
Di Federico Tavan è uscito da poco Augh! in coedizione con le Edizioni Biblioteca dell´Immagine
di Pordenone.
Nel contesto del progetto "Libro condiviso" le poesie di Federico hanno aperto la collanina, con
elegante grafica di Emanuele Bertossi, "Poesia in viaggio". Sono stati diffusi, tra 2007 e 2009, i
primi undici volumetti con testi rispettivamente di: Federico Tavan, Lionello Fioretti, Elio Bartolini,
Premio Malattia della Vallata 2006, Premio Malattia della Vallata 2007,Pierluigi Cappello, Fabio
Franzin, Vincenzo Della Mea, Giovanni Tuzet, Rosanna Paroni Bertoja, Ida Vallerugo).
Che cosa state facendo ? Quali sono i "progetti" che più vi stanno a cuore?
Stiamo lavorando a diversi "progetti". Meglio parlarne a cose fatte. Ne scelgo a caso due:
- il Museo archeologico di Montereale "a misura di bambino": un luogo - con annessa Biblioteca
demoetnoantropologica di riferimento - dal quale uscire, e al quale ritornare, con molte domande e
molti dubbi e con qualche provvisoria risposta da rimettere in discussione.
Le ricerche archeologiche nel territorio di Montereale sono iniziate nel 1968. Ora è tutto già
predisposto per il Museo. Tra i ritrovamenti di assoluto valore storico, archeologico e
antropologico oltre alla necropoli protostorica di VIII-VII sec. a.C., c´è la cantina di una casa
interrata (la Casa dei dòlii, dei grandi vasi) del V sec. a.Cristo. Una struttura abitativa pressochè
unica nel suo genere. Si può ricostruirla in scala 1:1. È, tra l´altro, un compendio straordinario dei
problemi scientifici, di studio e di interpretazione interdisciplinare, che gli archeologici affrontano
quotidianamente. Uno scavo modello.
- l´Università della Prima Età (da zero a dieci a... cento anni) , con Facoltà unica, quella del Libero
Perché, con laboratori aperti a bambini e adulti insieme, ´del fare´ e ´del veder fare´, e attraverso il
pensare ´lento´. Si tratta di far respirare ai bambini (e agli adulti) aria non inquinata dalla pervasiva
superficialità del ripetere per sentito dire. Imparare facendo, guardando gli altri fare, pensando (´con
lentezza´) e ripensando) è forse ciò di cui i bambini oggi hanno bisogno in modo particolare,
affinché il nuovo - per molti aspetti affascinante e tutt´altro, o comunque non sempre, negativo
come si vorrebbe far credere per ipocriti moralismi - nel quale si trovano immersi, non li sommerga,
ma dia loro strumenti per trovarvi una propria autonoma collocazione di senso. Certo, "una goccia
non basta ", bisogna lasciar cadere tante gocce, con continuità e costanza.
Aldo Colonnello
Intervista per Diari supplemento in friulano de "Il Nuovo Friuli"